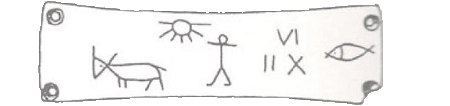| Gigi Sanna, Il professore
oristanese, autore di "Sardoa Grammata", è stato chiamato
dall'Associazione SardoLog per parlare della sua analisi ed interpretazione
del preziosissimo reperto sulcitano. Si tratta di una lamina di scisto
bruno, erroneamente definita dall'archeologia ufficiale "brassard"
(si veda in proposito l'articolo di Giorgio Cannas;
in Sardegna Mediterranea, 2000, anno IV, pp. 71-73) che contiene,
tra l'altro, chiaramente incisi, dei logogrammi, dei pittogrammi e dei segni
lineari di un alfabeto consonantico arcaico di tipo "protosinaitico".
Per
lo studioso esso risulta d'importanza e preziosità inestimabile
perché sarebbe la testimonianza di come culturalmente sia avvenuto
in Sardegna, intorno alla metà del II millennio a.C., un
certo sincretismo tra la millenaria sedimentazione religiosa, culturale
e linguistica indoeuropea e la religione, la lingua e la cultura delle
ondate semitiche colonizzatrici (cananee ed ebraiche) dell'età
del bronzo, sincretismo che produsse una civiltà dai caratteri
del tutto originali,espressione dei cosiddetti nuragici (ovvero dei costruttori
dei Nuraghi, delle Tombe dei Giganti e dei Pozzi sacri).
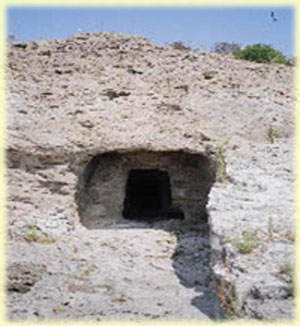 L'oggetto
di Is Loccis-Santus è un documento dalla cui analisi paleografica
e linguistica si evince, oltre alla denominazione della divinità
paleosarda chiamata DIO TORO ABI (luminoso) PADRE, il nome del sostantivo
"bidente" - b d n t -, parola con cui si chiamava in sardo nuragico
la Bipenne, simbolo certo, come si sa, della divinità astrale.
Un testo dunque con aspetti grafici, fonetici e linguistici
originari della Sardegna e non “importati” ma che, soprattutto, offrirebbe
la prova della presenza nell'Isola, oltre che della lingua semitica, di
un substrato linguistico sardo-indoeuropeo, preesistente alle dominazioni
preistoriche e storiche (cananee, sinaitiche, fenicio-puniche e romane).
Insomma il sardo non sarebbe una lingua solo romanza ma anche indoeuropea,
sorella quindi (e non figlia) del latino, dello stesso ceppo del greco,
del germanico, del sanscrito, ecc. Si può dire quindi che si è
aperta una finestra nel buio più totale, attraverso la quale si
può iniziare a leggere con prove "documentarie" (e non
solo indiziarie o mute) quella civiltà della Sardegna nuragica
che molti studiosi oggi, con gravissimo ritardo, dicono a parole di voler
studiare e conoscere ricorrendo all' interdisciplinarietà, ma che
nei fatti si ostinano ad ignorare, negando proprio il canale privilegiato
dei documenti scritti (proprio quello che potrebbe far uscire la Sardegna
dalla preistoria !). Numerosi infatti sono i reperti di scrittura nuragica
(rinvenuti anche dagli archeologi di professione, come il sigillo di S.
Imbenia di Alghero e la lamina di Pirosu su Benatzu) che Gigi Sanna ha
fatto conoscere al pubblico della conferenza, proiettando sullo schermo
le fotografie di testimonianze 'alfabetiche' provenienti da diversi siti
sardi, con codici espressivi davvero singolari, soprattutto se rapportati
ad altri identici o similari provenienti da altri luoghi relativamente
lontani ma vicini culturalmente come l'Anatolia, le coste siro-palestinesi
o le isole del mediterraneo orientale. L'oggetto
di Is Loccis-Santus è un documento dalla cui analisi paleografica
e linguistica si evince, oltre alla denominazione della divinità
paleosarda chiamata DIO TORO ABI (luminoso) PADRE, il nome del sostantivo
"bidente" - b d n t -, parola con cui si chiamava in sardo nuragico
la Bipenne, simbolo certo, come si sa, della divinità astrale.
Un testo dunque con aspetti grafici, fonetici e linguistici
originari della Sardegna e non “importati” ma che, soprattutto, offrirebbe
la prova della presenza nell'Isola, oltre che della lingua semitica, di
un substrato linguistico sardo-indoeuropeo, preesistente alle dominazioni
preistoriche e storiche (cananee, sinaitiche, fenicio-puniche e romane).
Insomma il sardo non sarebbe una lingua solo romanza ma anche indoeuropea,
sorella quindi (e non figlia) del latino, dello stesso ceppo del greco,
del germanico, del sanscrito, ecc. Si può dire quindi che si è
aperta una finestra nel buio più totale, attraverso la quale si
può iniziare a leggere con prove "documentarie" (e non
solo indiziarie o mute) quella civiltà della Sardegna nuragica
che molti studiosi oggi, con gravissimo ritardo, dicono a parole di voler
studiare e conoscere ricorrendo all' interdisciplinarietà, ma che
nei fatti si ostinano ad ignorare, negando proprio il canale privilegiato
dei documenti scritti (proprio quello che potrebbe far uscire la Sardegna
dalla preistoria !). Numerosi infatti sono i reperti di scrittura nuragica
(rinvenuti anche dagli archeologi di professione, come il sigillo di S.
Imbenia di Alghero e la lamina di Pirosu su Benatzu) che Gigi Sanna ha
fatto conoscere al pubblico della conferenza, proiettando sullo schermo
le fotografie di testimonianze 'alfabetiche' provenienti da diversi siti
sardi, con codici espressivi davvero singolari, soprattutto se rapportati
ad altri identici o similari provenienti da altri luoghi relativamente
lontani ma vicini culturalmente come l'Anatolia, le coste siro-palestinesi
o le isole del mediterraneo orientale.
Lidia Flore, direttrice dell'Associazione
SardoLog, nel presentare il lavoro dello studioso ha posto, tra l'altro,
l'accento sulla grave incuria in cui versa l'enorme e prezioso patrimonio
archeologico del Sulcis, negligenza di cui è emblematica la incredibile
"sparizione" della lamina nuragica scritta di Is Loccis-Santus
oggetto della Conferenza di Carbonia. Il cosiddetto brassard infatti si
trova sì, commentato e fotografato, nella pubblicazione
del ponderoso e prestigioso volume "Carbonia - Archeologia e Territorio",
ma non è mai apparso nelle vetrine né del museo civico di
Carbonia (Villa Sulcis) né in nessun altro museo. Dove si trova?
E così spuntano delle
domande numerose e un po' inquietanti :
Perché tra amministratori,
cittadini e persone di cultura, nessuno si interessa delle sorti dei "tesori"
culturali del proprio territorio ?
Perché chi detiene per "legge" e/o a proprio arbitrio
non interpreta (o fa interpretare, quando non ha competenza) i documenti
"chiaramente" scritti, talora facendo finta che essi non esistano
?
Perché c'è la tendenza a non agevolare in alcun modo la
fatica di studiosi e di interpreti preparati e in grado di farlo?
Di che cosa, soprattutto, si ha timore ?
Perché talvolta la "scienza" è proprio l'opposto
del suo significato, ovvero "non conoscenza" ?
|